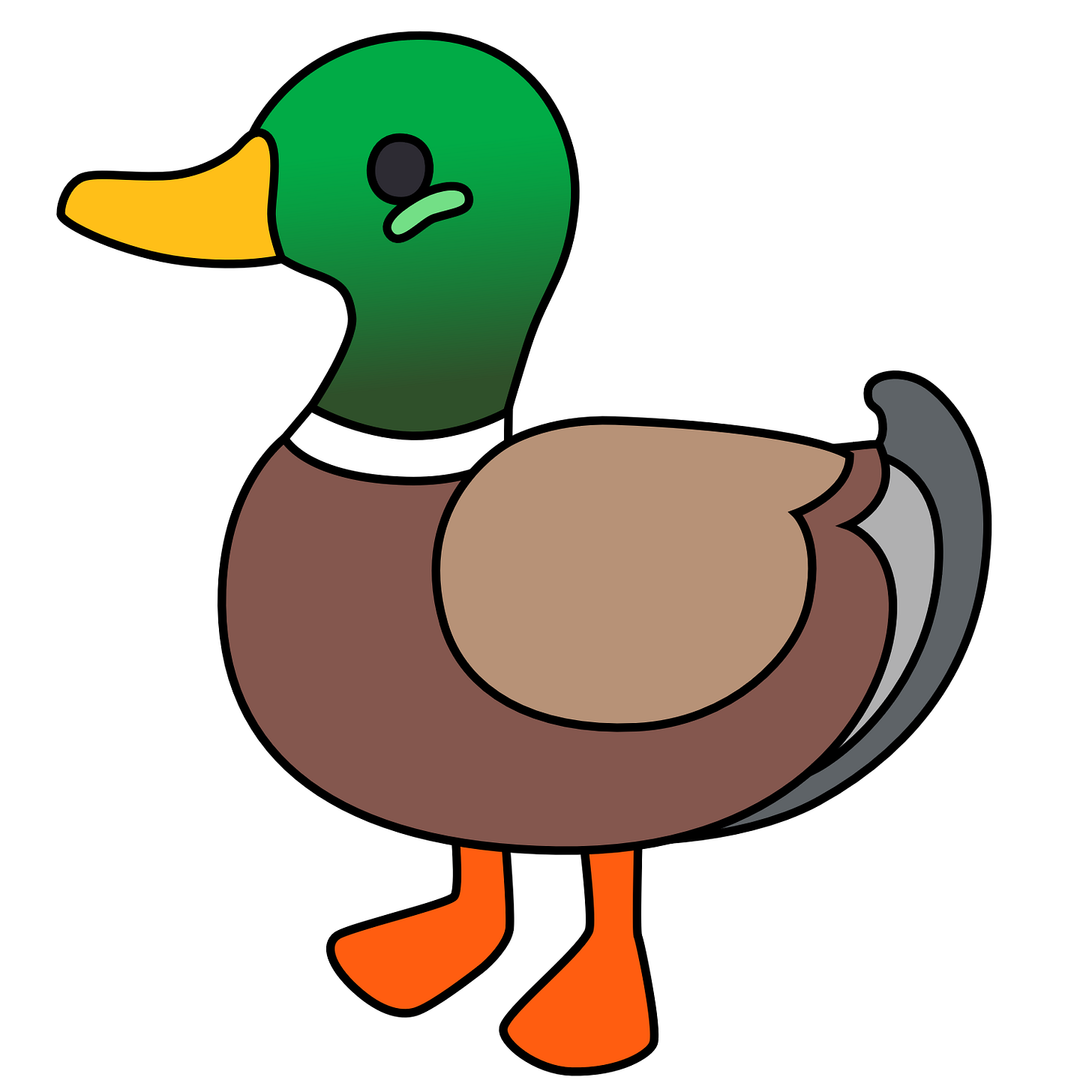Scatti ribelli
Ovvero di come la fotografia congeli lo sguardo su corpi che soffrono ma che continuano a occupare il loro spazio, testardi e presenti.
We have been sad long enough to make this earth either weep or grow fertile.
Audre Lorde, The Cancer Journals
Il mio corpo e la mia mente si trovano al momento su due binari diversi. Non sono nemmeno sicura stiano procedendo nella stessa direzione. Senza alcun dubbio viaggiano a due velocità completamente differenti.
Ricordo non senza una nota di nostalgia quel sentimento d’amore e di vicinanza che nutrivo per il mio corpo prima della malattia. C’erano giorni difficili, certo, come in qualunque relazione. Giorni in cui sfioravo le dita (e gli occhi) su centimetri di pelle che non ritenevo bella né degna d’attenzione; giorni in cui lui, il mio corpo, mi guardava da un angolo, cucciolone, e io non trovavo le parole per dirgli semplicemente “ehi, tu, ti voglio bene”. Anche in quei giorni, però, brillava un amore tondo, presente, splendido. Taciuto, forse, ma c’era. Un amore che trovava radici e spiegazioni nei sentimenti di conoscenza e di riconoscimento di me stessa.
Con la malattia, questo amore non è di certo scomparso, ma è sicuramente cambiato. Dopo la prima ondata di rabbia (che però devo dire è durata davvero poco, per me), è arrivata la compassione, il patimento collettivo, e con lui il dolore. Quando il dolore è vivo, si fa presente, non c'è via di fuga in nessuna direzione. Non esiste il futuro. Non esiste il passato. È la sintassi di una grammatica nuova. Una senza nomi né pronomi. Un linguaggio fatto solo di verbi. Respira. Sopravvivi. Resisti. Ora che il dolore parla più piano, provo tanta tenerezza. È amore, certo che lo è, ma ha una coniugazione diversa. Entra in punta di piedi, non fa rumore. Spesso chiede scusa.
Come ho già detto in un’altra puntata, questa qui, con il primo ciclo di chemioterapia ho iniziato a perdere i capelli; il 10 dicembre 2023 mi sono fatta un selfie, e l’ho caricato su IG:
L’ho fatto senza rifletterci troppo - non era il primo selfie che mettevo sulla piattaforma e non sarebbe stato di certo l’ultimo.
Costruire memorie
Poi, mentre i giorni trascorrevano, e io provavo ad accogliere dentro la mia vita e dentro le mie pupille l’espressione nuova del mio viso, le forme nuove del mio corpo, mi sono detta - perché non avere delle foto più carine, magari scattate da qualcunə che sappia usare una fotocamera? Ho pensato alle mie migliaia di foto online (su una nuvoletta o su una piattaforma, poco importa) provando a creare un catalogo mentale: ho foto delle mie lauree, foto del mio dottorato, foto del mio matrimonio (che figa che ero!), foto coi miei nipoti, foto con amicə, foto con la famiglia, foto con il cane della famiglia, foto di drink, di cibo, di viaggi - you name it!
Abbiamo fotografie per ogni ricorrenza e ogni evento delle nostre vite. E allora perché non abbiamo fotografie che catturino anche i momenti difficili? Le lacrime, la sofferenza. Perché non abbiamo fotografie di funerali? O delle nostre malattie? Perché non abbiamo scatti del lato notturno della vita? Della cittadinanza più onerosa che purtroppo prima o poi ci tocca vivere?
Forse perché facciamo in fretta a dimenticare. Perché dobbiamo dimenticare per poter riprendere a vivere. Azzardo, eh. Ma io non volevo, non voglio, dimenticare. Voglio guarire, certo, ma non voglio e non posso fare finta di niente. Devo di più, al mio corpo e al mio cuore, dell’oblio. Voglio costruire una memoria, una che passi attraverso le parole, e, perché no, attraverso la fotografia.
Così un giorno ho incontrato Elisa Maenhout, una giovane fotografa di Gent; ci siamo piaciute subito, e abbiamo deciso di fare degli scatti assieme: questa puntata di Fate ə monellə ne contiene alcuni.

È stato terapeutico farsi fotografare. Ha reso il mio corpo reale. Vivo, vero. Diverso, senza dubbio. Ma autentico. Ha reso l’invisibile visibile. In un momento di grande fragilità e debolezza, mi sono sentita potente. Immortale. Invincibile, quasi.
Scatti politici
Non sono la prima donna con un cancro al seno a ricavare senso di identificazione ed “empowerment” dai click di una macchina fotografica. Una ricerca online mi ha fatto scoprire la storia e il lavoro di Jo Spence, fotografa e attivista britannica diagnosticata con un cancro al seno nel 1982. Nel suo lavoro “The Picture of Health”, Spence si pone una domanda ben precisa:
come si può rappresentare un corpo in crisi?
La domanda è innanzitutto politica, oltre che artistica. Come si abita un corpo in crisi? E come può trovare ragion d’essere, rappresentanza?
Spence decide di sancire, attraverso la fotografia, la proprietà del suo corpo e il suo diritto di autodeterminazione. Documentando il suo viaggio contro e con il cancro, porta alla luce quello che invece tendiamo in genere a nascondere: un fisico non convenzionale, dove la malattia non è più accessorio, un evento che succede, un’onda che ci prende in pieno e ci fa annegare, ma diventa protagonista, assieme al corpo che fa di tutto per rimanere presente, autonomo, capace. Testardo.

La malattia invade l’obiettivo fotografico.
Con lei gli strumenti che servono per interrogare il corpo, per costruire un dialogo, per cercare risposte, sperando che arrivino.

È anche quello che ha fatto Eleonora Ghioldi durante la sua convivenza con il cancro al seno: raccogliere foto, testimonianze, immagini e parole che documentassero un viaggio lungo e faticoso. Ma un viaggio in cui Ghioldi rimane protagonista.
Nelle sue parole:
Cancer changed my life, photography saved me.
Il cancro mi ha cambiato la vita, la fotografia mi ha salvato.
Così il suo progetto, The Breast Cancer Project, è una collezione di memorie intime che mostrano i segni unici di un percorso del tutto personale, eppure di dimensione collettiva. Fotografie clandestine che raccontano di farmaci, sangue, ferite, cicatrici, perdite, su un corpo che soffre ma che continua a occupare il suo spazio. E che lo fa anche in relazione all’altrə. Anche, e forse soprattutto, nella malattia.
Io non lo so, se la fotografia m’ha salvato. Forse sono state di più le parole.
Ma è stata in grado di riportarmi a quella sintassi senza nomi né pronomi, a quel linguaggio presente fatto di verbi che non conosce passato né futuro.
E che solo sa dire - ora, ora, ora.

La fotografia ha congelato il mio sguardo. E, nel farlo, lo ha spostato, da una parte all’altra di una conversazione collettiva di cui non sapevo nemmeno di aver bisogno. L’ho sentito forte e chiaro mentre posavo per Maenhout. Un patto tacito di fiducia tra me e lei, tra il mio corpo, e il suo, tra i miei occhi, e la sua lente.
Un patto che dice “tu ci sei, e io ti vedo”.
Un patto che adesso estendo a voi, che leggete, che guardate.
Cose che ho letto, visto, sentito
Ho letto questa poesia di Wendy Cope che voglio scrivere a penna su fogli colorati pieni di fiori da regalare a tutte le persone che amo. “I love you. / I’m glad I exist.”
Ho visto la prima stagione di Prisma, una serie che esplora le identità di due gemelli adolescenti, passando per un sacco di roba che avrei voluto vivere e sentire io venti anni fa, quando ero una teenager. Aspetto con ansia che la seconda stagione arrivi in Belgio, e poi vi dico.
Perla finale (if you know, you know): le lettere tra Alexander Hamilton e John Laurens: “You sh⟨ould⟩ not have taken advantage of my sensibility to ste⟨al⟩ into my affections without my consent.1” ♥︎
A giovedi prossimo, fate ə monellə, e se vi va raccontatemelo pure!