Parola a unə monellə - I
La prima puntata di una nuova rubrica in cui io parlo di meno, e lascio la parola, e la scrittura, a unə di voi. Invalidità, disabilità, abilismo, bisogno di parole nuove. A parlare, oggi, è Tiziana.
Altrove è tutto tranne me. Solo poi, sono diventato veramente io.
Carə monellə,
benvenutə a una nuova rubrica di questa newsletter, una rubrica che ho praticamente inventato in questo preciso istante, a poche ore dall’invio di questa puntata. Si chiama “Parola a unə monellə” ed è lo spazio in cui io me ne sto un po’ in silenzio, o comunque parlo di meno, ed è invece una persona che legge questa newsletter a parlare di una cosa o due. Di qualunque cosa, in verità, perché ormai lo sappiamo che il piano editoriale di questo spazio fa un po’ ridere, e che qui dentro è tutto un po’ liquido: prende la forma del recipiente, e il recipiente è un contenitore di colori, pensieri, domande, scorre come un fiume e a noi ci piace così.
Il primo episodio di questa rubrica prova a seguire la rotta dell’ultima puntata, quella in cui vi raccontavo del mio incontro con una parola nuova che faccio molta fatica ad accogliere e a digerire nella mia vita: invalidità. Mi sono messa a fare ricerche, a studiare, a interrogarmi, ne ho parlato in terapia, in famiglia. Poi mi sono detta che dovevo cercare altrove, in un posto abitato da tempo, da persone che questa roba qui la masticano da anni. Mi è venuta in mente Tiziana Masoch, che ho conosciuto dentro la mia bolla onlife grazie a Elena Panciera (una bolla e una vita che non chiamo più virtuale, perché è assolutamente reale, e non vive in potenza ma in atto1). Così ho chiesto a Tiziana di rispondere a qualche domanda per me2, di condividere con me - e quindi con voi - qualche pensiero, di prendere la parola dentro questo contenitore, insomma. Le sono molto grata, ma adesso lo spazio è suo, e le mie (poche) parole per lei arrivano dopo, giuro.

Ciao Tiziana, ti va di dirci un po’ di te? Qualsiasi cosa pensi che le persone che leggono questa newsletter siano interessatə a sapere. Qualsiasi cosa tu voglia condividere con noi.
Sono Tiziana e vivo in un piccolo paese del bellunese. Sì, Belluno, la città più piovosa d’Italia, pensate che gioia. Amo il sole e il mare quindi sì, sono nata proprio nel posto giusto. Sono una traduttrice editoriale, o almeno ci provo. Sono disabile e mi muovo in carrozzina. Amo le parole, i libri, le differenze, le menti aperte, l’ironia (questa parte è tratta dalla mia bio sulle dating app. Sì, uso le dating app, ma questa è un’altra storia). E soprattutto sono monella, se no non sarei qui.
Aggiungo una domanda io: serie televisiva del cuore? Quella che la guardi e improvvisamente stai meglio?
La prima che mi viene in mente è Fleabag, più che altro perché credo sia quella che ho visto più volte. Mi sento molto come lei, nel suo cercare il suo posto nel mondo, nella sua visione un po’ cinica e ironica della vita, nel suo provarci, anche nelle relazioni impossibili. La guardo spesso quando sono giù e così mi sento meno sola, soprattutto quando abbattendo la quarta parete Fleabag cerca il mio sguardo e io mi rendo conto di pensare quello che pensa lei. Non mi sono mai innamorata di un prete ma in quanto ad amori impossibili anch’io non scherzo. - I love you. - It’ll pass. (cit.) (ma anche tratto da una storia vera).
Nell'ultima puntata di Fate ə monellə ho raccontato di come sia arrivato per me il momento di fare i conti con una parola nuova: invalidità. Ti va di dirci che posto occupa questa parola nella tua vita, e come ti fa stare?
La parola “invalidità” non mi piace per niente. Nella mia vita non c’è posto per lei, se non nelle scartoffie che ogni tanto devo tirar fuori per dimostrare che la società non mi prevede ancora, se non come un essere umano che non rientra nella norma. Nella burocrazia questa parola è infatti ancora largamente utilizzata (certificato d’invalidità, pensione d’invalidità, invalidə civile). Mi inquadra e mi fa sentire “non valida”.
Ma come non valida? Non valgo come essere umano? Non posso essere utile? Sarò sempre un peso per la società? La mia condizione di invalidità è cronica, non c’è cura per me, non è una situazione temporanea. Ma io non mi sento non valida, io so di avere un valore, è la società, forse, a essere invalida perché difetta nel non prevedere la presenza di tuttə. Io sono disabile, ma non sono invalida. Disabile è una parola meno impattante, il prefisso dis- mi fa meno male del prefisso in-. E anche la parola abile è meno forte della parola valida. Posso non essere abile a fare qualcosa, a giocare a calcio per esempio, ma resto comunque valida. Questi sono solo miei sproloqui mentali, non hanno certo valore universale, ma magari da qui può partire qualche riflessione.
Accennavo anche all’abilismo che mi rendo conto di dover decostruire dentro di me. È un processo complesso ma necessario. Che impatto ha nella tua vita?
Nell’abilismo ci vivo da sempre, ci viviamo tuttə da sempre, da una parte o dall’altra, o meglio, in uno spettro di colori sempre più luminosi a mano a mano che le fette di prosciutto (rigorosamente veg) ci cadono dagli occhi. La società è profondamente abilista, ci insegna che chi è disabile è difettosə, non funziona, non può stare allo stesso livello delle persone “normodotate” (sì, le virgolette sono volute), non è abbastanza. Il problema sono le persone disabili che non possono stare al passo con le altre persone, e quindi è normale che non siano previste, mica si può modificare il mondo per loro. E quindi pure tu, persona disabile, impari a credere che sia vero, che sia giusto così, ti fai da parte e stai zitta in un angolino, per non disturbare. Questa cosa ha un nome: abilismo interiorizzato.
Cosa succede quando invece si ribalta la visione e si comprende che il problema non siamo noi ma la società? È la società che disabilizza, che non dà le stesse possibilità a tuttə mentre invece, per essere equa e giusta, dovrebbe farlo. Utopistico? Forse, ma necessario. Quando io l’ho capito il mio mondo è cambiato, e il processo di decostruzione è iniziato. L’impatto di questa consapevolezza è liberatorio e una cosa è certa: non si torna indietro. Sono una donna disabile, non sono autonoma e fino a qualche tempo fa me ne vergognavo. Ora no, ho bisogno d’aiuto per moltissime cose, compresa la mera sopravvivenza, e quindi? Vorrei vivere in uno stato che mi garantisca l’assistenza per poter vivere. Vorrei uno stato che non si limiti a uno sterile assistenzialismo, ma che permetta l’indipendenza a tutte le persone disabili. Vorrei uno stato che non si giri dall’altra parte, ma che ci veda e ci ascolti. Chiedo troppo? Lascio questa domanda in sospeso, ma io la mia risposta la so.

C'è bisogno di parole nuove. Ce lo siamo dette in privato, e continueremo a dircelo. Che parole usi per parlare della tua identità? Quali non sopporti? Che parole vorresti fossero usate?
Io mi definisco persona con disabilità o persona disabile. Uso sia il linguaggio “person-first” (dall’inglese “person with disabilities”) sia il linguaggio “identity-first” (dall’inglese “disabled person”). Secondo il primo approccio, l’accento è posto prima sulla persona con l’obiettivo di sottolinearne l’umanità e il valore intrinseco, considerando la disabilità come una delle sue tante caratteristiche. Con il secondo approccio, invece, si mette la disabilità al primo posto, riconoscendola come parte integrante dell’identità della persona, non come qualcosa di separato, ma come un aspetto essenziale di sé. Inoltre, in inglese c’è un’ulteriore sfumatura di significato che in italiano si perde: disabled person indica una persona “disabilitata” dalla società. Ecco, “disabilitatə” potrebbe essere un neologismo che magari entrerà nell’uso, chi lo sa… Tornando a persona e identità, per me gli approcci sono entrambi validi, anche se ultimamente, con il processo di decostruzione del mio abilismo interiorizzato, sento più forte la necessità di sottolineare la mia identità di persona disabile.
Ci sono invece parole che non sopporto e che non vorrei più sentire, tipo: invalida (come ho già detto), handicappata, diversamente abile, tutte parole che si portano dietro un carico di stigma e pregiudizio che la comunità disabile non è più disposta a sopportare. Anche locuzioni come “affettə da…”, “costrettə su una carrozzina”, non si possono più sentire, ma purtroppo sono ancora largamente utilizzate, soprattutto nel giornalismo. Non lo sentite il pietismo e la negatività che si portano dietro?
Vorrei parole nuove, gentili e rispettose, che prevedano tuttə e rispecchino l’identità di ognunə. E mi piacerebbe inventarle insieme. Di questo si potrebbe parlare per ore, e mi piacerebbe davvero farlo.
Nel frattempo, per chi volesse approfondire, mi sento di consigliare due libri: Lo spazio non è neutro di Ilaria Crippi e Felicemente seduta di Rebekah Taussig, nelle loro parole mi sono sentita vista e rappresentata.
Spero vi sia piaciuta questa rubrica, ma soprattutto l’idea di rendere questo spazio più collettivo, corale, diverso. Non so quando uscirà la seconda puntata, navighiamo a vista e vediamo dove ci porta questo fiume. Tiziana mi ha fatto riflettere su tante cose, e spero abbia mosso un po’ la corrente anche nelle vostre teste.
Grazie, Tiziana, per il tempo e le energie che hai dedicato a Fate ə monellə, spero di incontrarti fisicamente, prima o poi: un concerto, un gelato, un pippone lunghissimo su uno dei tantissimi libri che hai tradotto e traduci, parole nuove che inventiamo assieme. Sarebbe bellissimo <3
Cose che ho letto, visto, sentito
Inizia proprio oggi che esce la newsletter il Festival DiParola. Tante persone in gamba per parlare di linguaggi chiari, inclusivi, accessibili. Lo seguirò in diretta!
Ho una lista infinita di libri da leggere (o che vorrei leggere): ho iniziato da “La straniera”, di Claudia Durastanti (grazie a Eleonora per il regalo!). Vi farò sapere, ma penso già che aprirà una o due ferite nel mio cuoricino isolano.
I saggi su
regalano sempre emozioni bellissime (e quanto bene sono scritti!). L’ultimo è di Guillem Clua, drammaturgo, sceneggiatore e regista spagnolo. Ha scritto un’opera teatrale di nome Smiley che è poi diventata una serie TV su Netflix (l’ho messa in lista!). Dall’ultima newsletter: “I realized that by using the narrative mechanisms of classic rom-coms, I had written an idealization of romantic love that, no matter how successful it was and how much it was making people happy, was making me feel more and more miserable. The standards of romantic comedies are unattainable. Using them as a reference for a healthy relationship is as effective as comparing your sex life to a porn movie or trying to achieve Chris Hemsworth’s physique without steroids.3”
A presto, fate ə monellə!
E di questo scriverò sicuramente, un giorno, di come internet mi abbia cambiato (salvato?) la vita.
Le mie domande sono in grassetto, le risposte di Tiziana seguono.
Mi sono reso conto che, utilizzando i meccanismi narrativi delle commedie romantiche classiche, avevo scritto un'idealizzazione dell'amore romantico che, per quanto avesse successo e rendesse felici le persone, mi faceva sentire sempre più infelice. Gli standard delle commedie romantiche sono irraggiungibili. Usarli come riferimento per una relazione sana è efficace quanto paragonare la propria vita sessuale a un film porno o cercare di ottenere il fisico di Chris Hemsworth senza steroidi.




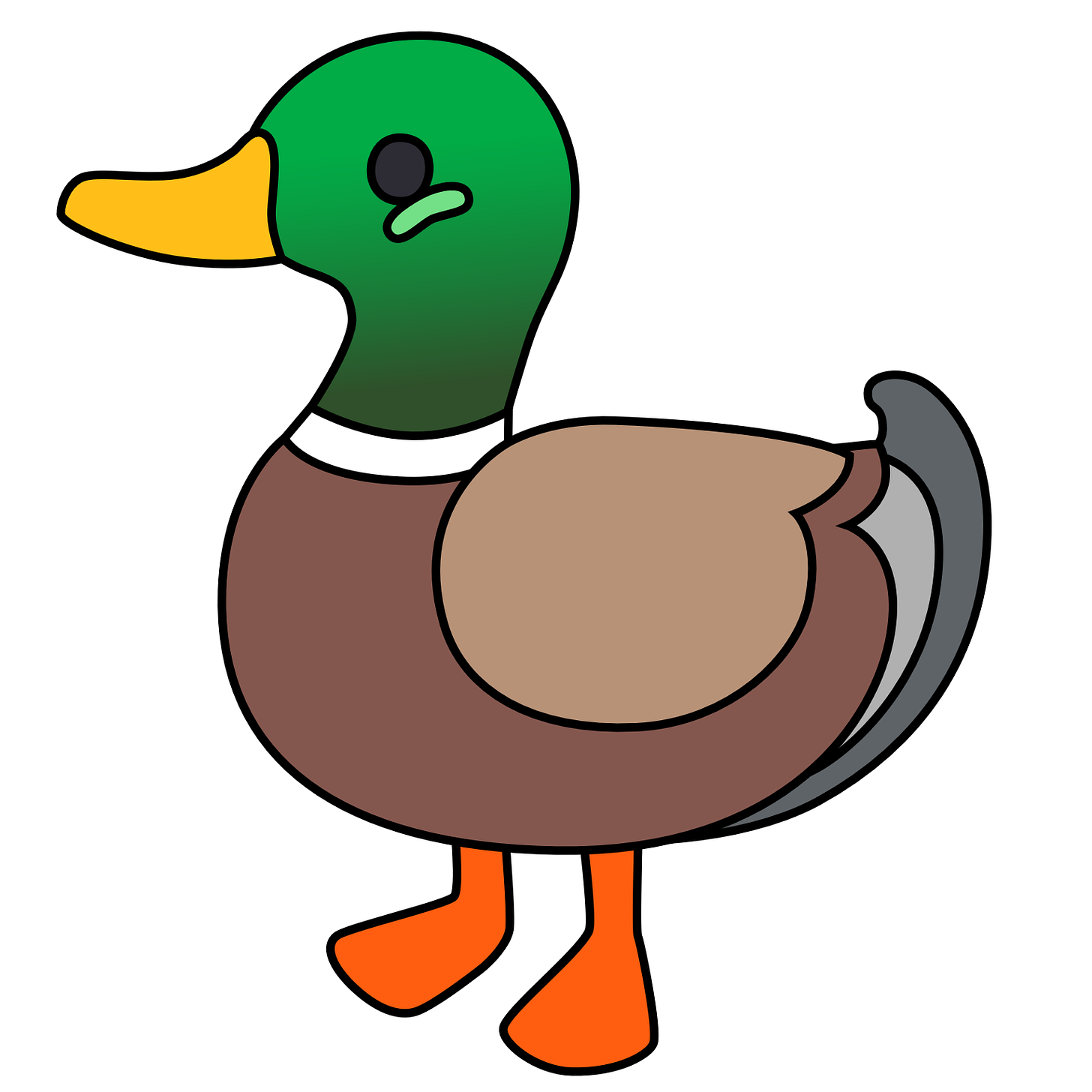
Una rubrica che ci piace tanto, grazie a te e Tiziana per aver creato questo spazio in cui far brillare le vostre parole 💚
Che bellezza, due delle mie persone preferite al mondo che si incontrano! 🥰 Grazie per averci regalato questa chiacchiera.